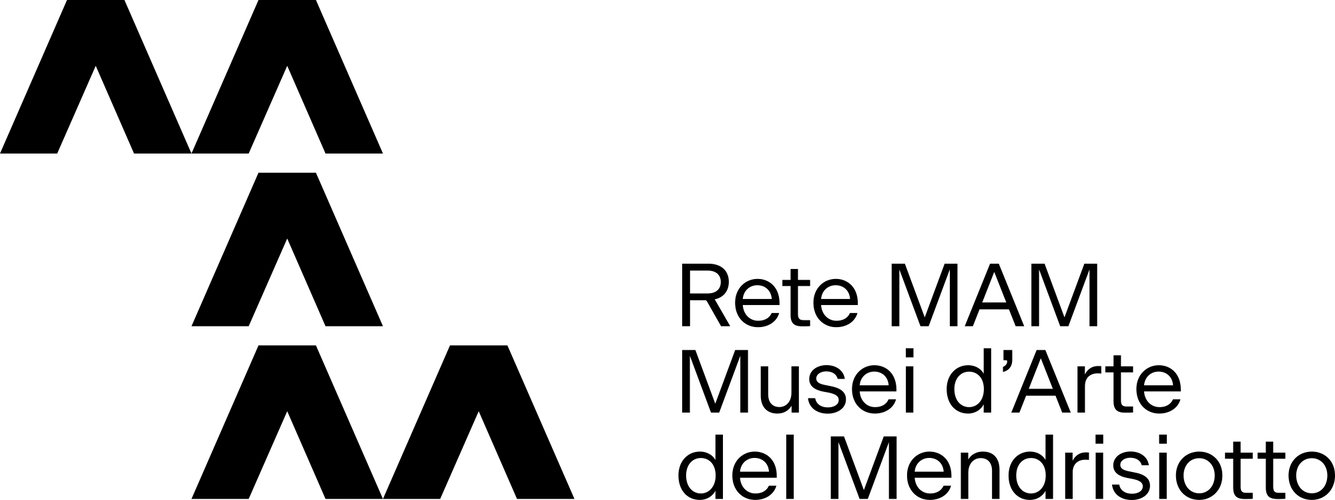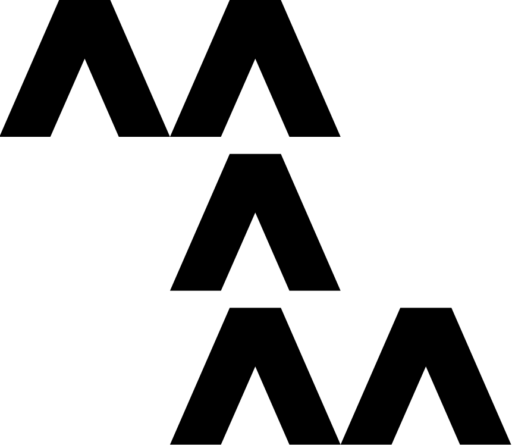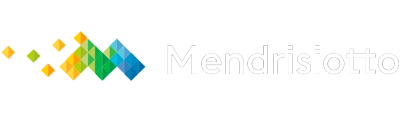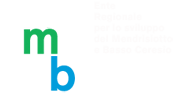Vela dopo il 1867, anno del rientro nel Mendrisiotto
Ritornato definitivamente a Ligornetto nel 1867, Vincenzo Vela affiancò l’attività artistica a un operoso impegno politico e sociale a favore dei propri concittadini e delle fasce più sfavorite della popolazione ticinese. Fedele al suo credo di essere anzitutto cittadino svizzero prima ancora che artista, lo scultore fu deputato al Gran Consiglio dal 1877 al 1881 e membro del Consiglio cantonale di pubblica educazione dal 1862 al 1877, in seno al quale si spese soprattutto per il rafforzamento delle scuole di disegno. Sempre in ambito educativo, Vela lottò in prima persona, purtroppo invano, per l’istituzione di una scuola di belle arti in Ticino. Convinto repubblicano, «informato a principii liberali», non mancò mai di affermare i suoi ideali politici. Membro di numerose società di mutuo soccorso, grazie alla sua munificenza, che si manifestò anche dopo la morte attraverso il lascito di Spartaco, Ligornetto poté migliorare le proprie infrastrutture pubbliche. Con il rilievo delle Vittime del lavoro, liberamente realizzato nel 1882 e ispirato ai caduti sul cantiere della galleria ferroviaria del San Gottardo, Vela scrisse il manifesto delle istanze sociali e umanitarie. L’opzione di Vincenzo Vela a sostegno dei più sfavoriti ci ricorda un altro filantropo da lui effigiato, il conte Alfonso Turconi, il cui lascito permise la fondazione a Mendrisio di quello che diventò l’Ospedale della Beata Vergine, oggi sede dell’Accademia di architettura, accanto alla quale sorge il Teatro dell’architettura.
Villa Vela nella Campagnadorna di metà
Ottocento
Tra il 1862 e il 1866, su un vasto appezzamento collinare a nord di un villaggio rurale, vide la luce un’imponente villa edificata dall’architetto Isidoro Spinelli di Sagno su disegno di Cipriano Ajmetti, architetto dei Duchi di Genova. Dimora della famiglia Vela, ma anche atelier dello scultore e galleria dei suoi gessi, nella Campagnadorna di metà Ottocento il signorile edificio – che si meritò presto il titolo di «Pantheon Vela» – poteva incutere deferenza e soggezione. In realtà lo scultore divideva fraternamente la casa e la mensa con quanti ne avevano bisogno, e non è un caso che alla sua morte, attraverso il lascito di Spartaco, la villa divenne il primo museo pubblico del Ticino (1896). Genio delle arti ma di umili origini contadine, Vela non disdegnava il lavoro della terra che lo avvicinava così alla maggioranza dei suoi concittadini, tanto che, ancora residente a Torino, scriveva in una lettera dal soggiorno autunnale a Ligornetto che «in questi due mesi di vacanza io non sono più artista ma bensì campagnolo e cacciatore», geloso dei suoi segugi, per i quali nutriva una passione smisurata. A Rancate, dove oggi sorge la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Vela possedeva una cantina in cui conservava un «nettare» che spesso amava condividere con amici e colleghi. E in questo quadro sostanzialmente idilliaco non manca una pagina di cronaca nera, quando, nella notte del 6 marzo 1867, mani ignote esplosero a scopo intimidatorio due colpi di carabina contro la villa. Forse un avvertimento, ma i cui moventi rimasero sconosciuti.
La tradizione scultorea del Mendrisiotto e le cave di marmo
Arzo, Besazio, Viggiù: località a cavallo del confine e vicine a Ligornetto, conosciute per le loro cave e le diverse qualità di pietre. Perciò terre di scalpellini, ornatisti e scultori che, dopo aver esercitato l’arte muratoria spesso all’estero, lasciavano in patria eloquenti tracce della loro maestria. Tra questi ricordiamo almeno Apollonio Pessina, per quasi un quarantennio curatore del nostro Museo. Anche Vincenzo Vela, ancora bambino, fu avviato alla professione di scalpellino nelle vicine cave e, attorno al 1834, raggiunse il fratello maggiore Lorenzo, scultore d’ornato, a Milano per proseguire l’apprendistato presso il cantiere del Duomo. È in questo 2 contesto e da queste umili origini che nasce il genio artistico dello scultore e che trovò poi nutrimento nell’antica tradizione culturale italiana. La sua gipsoteca certamente spicca rispetto alle più modeste e appartate testimonianze della precedente e coeva tradizione scultorea. Presenza forse autocelebrativa, ma in realtà ospitale luogo di arricchimento spirituale e di formazione, avendola sin dall’inizio destinata alla pubblica fruizione, poi confermata attraverso il lascito alla Confederazione svizzera con l’impegno a crearne un museo o una scuola d’arte. Tra le opere della gipsoteca troviamo l’Ecce Homo, una replica marmorea del quale veglia sulle spoglie mortali di Vela nel cimitero di Ligornetto. Il monumento, eretto dal figlio Spartaco e da alcuni ex allievi del Maestro, è stato restaurato in occasione del bicentenario della nascita dell’artista grazie al cospicuo sostegno della Città di Mendrisio. Mendrisio dove trova sede il Museo d’arte cittadino.
Il confine che ha segnato la storia del Mendrisiotto e di Vincenzo Vela
Ligornetto sorge a pochi passi dalla frontiera con l’Italia. Come spesso accade, il confine fu più spesso punto d’incontri e di scambi che non linea divisoria. Per Vincenzo Vela la frontiera non fu certo un discrimine: cittadino e artista, patriota svizzero – per la sua fede repubblicana e liberale che lo vide al fronte nella guerra del Sonderbund – e italiano con la sua volontaria partecipazione ai moti risorgimentali e, ovviamente, per l’ispirazione artistica. Ed è lo stesso scultore a dichiarare che il confine non era per lui una barriera: «I miei principi in politica sono mondiali, e prenderò sempre parte per quel popolo che cerca la sua indipendenza dallo straniero, e che tenta di avanzare nella via della libertà e del progresso…». Non per nulla il salone centrale della sua villa raccoglie su suolo elvetico la storia dell’Unità d’Italia. Parlare di confine nel Mendrisiotto non può che condurci a Chiasso, porta meridionale della «via delle genti», dove troviamo il m.a.x. museo, ispirato a un altro artista che visse il confine come luogo di incontro e di scambio: lo zughese Max Huber. Per concludere con un tocco di spensieratezza, si narra che in un roccolo di sua proprietà Vela amasse ritirarsi a trascorrere qualche ora di riposo e a uccellare indisturbato, pratica venatoria proibita in Svizzera ma non in Italia. Infatti per pochi metri il roccolo sorgeva in territorio italiano ma ancora al di qua della rete daziaria… Un sotterfugio veniale per le autorità del Regno che, forse, chiudevano un occhio, memori dell’impegno di Vela nelle lotte risorgimentali.